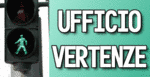MA IL LAVORO E' UNA MERCE?
Questo articolo, di Gianni Loy (professore ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Cagliari), è stato pubblicato nel N. 35 del Manifesto Sardo
Se Air France o Lufthanza potessero pagare a metà prezzo il kerosene, o se le società aeroportuali applicassero tariffe differenziate per favorire le rispettive “compagnie di bandiera” dei rispettivi paesi, ci troveremmo di fronte ad una palese violazione dei tanto sbandierati principi della concorrenza.
Ma se una compagnia aerea, per rimanere nel mercato in posizione concorrenziale, o per sopravvivere, dimezzasse le retribuzioni dei propri dipendenti non corre alcun rischio di incorrere negli strali di Bruxelles. E perché mai? Non è forse semplicistico per una compagnia aerea, stare a galla, in questo caso in aria, grazie alla possibilità di risparmiare pesantemente sui salari? Così son buoni tutti, si direbbe dalle nostre parti.
Il lavoro è una merce. Uno dei fattori della produzione assieme a materie prime, apparecchiature, tasse e kerosene. Ma, curiosamente, mentre la maggior parte di quei beni ha un costo fisso, o quasi, scarsamente negoziabili, sul lavoro sono consentiti ampi margini di manovra. Eppure è la merce più pregiata, perché coinvolge uomini e donne, persone, sino a determinare la qualità della loro esistenza. Perché la CAI non sceglie di risparmiare sul kerosene, o sull’Iva, o sui diritti aeroportuali?
La verità è che questa merce, il lavoro, si va deprezzando. E’ diventato il ventre molle di una globalizzazione che alcuni dei suoi fautori, anche da noi, incominciano a rinnegare ed a vedere con sospetto.
Qualche giorno fa, in un quotidiano di Madrid, veniva esaltato il fatto che nella provincia si è registrato il minor incremento del costo del lavoro di tutta la Spagna. E c’è per questo da stare allegri? Certamente! Perché la morale, peraltro esplicita, era costituita dal conseguente invito ad investire in quel territorio, reso più appetibile dal minor costo del lavoro.
La questione è che si è smesso di esaminare i fenomeni dal punto di vista del lavoro, della dignità e dei bisogni delle persone, considerandoli una “semplice” variabile dipendente dalle fortune dell’impresa.
In questi giorni si sta aprendo una fase di discussione tra sindacati e Confindustria che potrebbe rimettere in discussione una conquista della classe operaia di quasi mezzo secolo, fondata sul doppio livello di contrattazione, quella nazionale di categoria e quella, peraltro eventuale in funzione della forza contrattuale del sindacato nell’azienda. Sarebbe sufficiente un solo livello, volendosi privilegiare quello aziendale, dove a sua volta si vorrebbe che il salario fosse sempre più misurato sulla base della produttività e della redditività dell’azienda. L’ipotesi affascina. Come tutte quelle che promettono, anche se semplicisticamente, semplificazioni burocratiche. Ci casca anche qualche commentatore ritenuto “in quota alla sinistra”, come se il cambiamento fosse sinonimo di progresso. Ma la contrattazione nazionale, secondo l’assetto attuale, quello concordato con il protocollo del luglio 1993, è volta proprio a stabilire i livelli minimi contrattuali per tutti gli appartenenti alla categoria, compreso il recupero dell’inflazione, dopo la scomparsa della scala mobile, per tutti, compresi soprattutto quelli che non hanno l’opportunità o la forza di incrementare il proprio salario mediante la contrattazione aziendale, oggi riservata ai soli incrementi salariali legati alla produttività ed alla redditività.
Eliminare il livello nazionale, soprattutto in un sistema, come quello italiano, dove non esistono minimi salariali fissati per legge, significherebbe una grave perdita di tutela per i lavoratori di più basso reddito. I lavoratori “forti”, infatti, in un modo o nell’altro, riuscirebbero probabilmente a cavarsela anche ricorrendo al contratto individuale, pericolosa lusinga che ormai sta dietro l’angolo e che finirebbe ancora una volta per togliere ai poveri per dare ai ricchi (relativamente).
L’art. 36 della Costituzione, peraltro, che garantisce anche a livello giudiziario una retribuzione minima sufficiente “ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa” (sic!) trova oggi diffusa attuazione giudiziaria mediante un rinvio ai minimi salariali stabiliti dalla contrattazione nazionale di categoria. Il livello nazionale, insomma, è quello che fissa il salario minimo richiamato, storicamente, dalla nostra Costituzione. Peraltro, l’idea di ampliare sempre più la quota variabile del salario legata alla produttività, di per sé legittima se mantenuta entro limiti fisiologici, fa da schermo ad un altro possibile inganno. Legare le maggior retribuzioni alla redditività dell’impresa, posto che questa deriva non solo (a volte per niente) dalla qualità del lavoro dei dipendenti che, pur essendo elevata, può essere vanificata dalle scelte imprenditoriali, significa far gravare sui lavoratori il rischio di scelte strategiche errate dell’imprenditore.
Ma anche legarlo alla produttività può esser fonte di possibili equivoci, se si pensa che questa non dipende solo dalla capacità e dall’applicazione dei dipendenti. In tal caso è più che legittimo ed opportuno tener conto del rendimento individuale e collettivo dei lavoratori, a patto di contenerlo entro limiti che non ripropongano, sotto mentite spoglie (incentivo) i fenomeni più negativi del cottimo. Ma la produttività, sia chiaro, può anche dipendere dai sistemi di produzione e di organizzazione del lavoro adottati dall’impresa. In tal caso, ancora una volta il lavoratore finirebbe per accollarsi , almeno parzialmente.
Cambiare si può, certo, ma prestando la dovuta attenzione a quale sia la posta in gioco e quali le possibili conseguenze delle novità che i vorrebbero introdurre.
Gianni Loy - www.manifestosardo.org