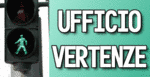Il quaderno del dolore operaio
Le parole del vescovo rimettono al centro l'uomo, il rogo di Torino ci costringe a vedere quel che la società di mercato ha rimosso: gli operai esistono, soffrono, pagano con la loro vita il rovesciamento dei valori. Un percorso a ritroso iniziato nell'80 che non ha cancellato la dignità di chi lavora.
Torino, la mia città d'adozione, una città da sempre laboratorio per la politica, per il sociale, per la cultura. Questo è un piccolo resoconto, in forma di diario, di un periodo difficile per Torino, segnato dal dolore, dalla rabbia, ma anche dall'amore, cominciato nella notte tra il 5 e il 6 dicembre, quando nell'acciaieria ThyssenKrupp è divampato un incendio che ha investito molti operai con le sue fiamme e ne ha uccisi sette.
L'uomo sul tetto. 11 dicembre, la manifestazione parte da piazza Albarello, nel centro città. Appena ci muoviamo, lungo via Cernaia, notiamo sulla sommità di un edificio un uomo che sta aggiustando le tegole del tetto. Lavora in condizioni di rischio, non ha il casco protettivo né sembra agganciato a un'impalcatura. Facciamo notare il paradosso a un cineoperatore: alcune migliaia di persone radunate per denunciare una tragedia nata probabilmente dall'assenza di sicurezza, e, a pochi metri, l'esempio lampante di quell'insicurezza. Invitiamo a riprendere, a documentare, ma l'invito cade nel vuoto. Lo stesso vuoto in cui, non metaforicamente, cadono tante, troppe persone. Tra il 2001 e il 2005 l'Italia ha avuto in media 1328 morti sul lavoro, quasi 4 al giorno. Negli ultimi due anni la media è leggermente calata - è giusto riconoscere l'impegno della politica, i provvedimenti presi, i controlli - ma resta altissima, più del doppio che in Francia, Germania, Gran Bretagna, paesi a cui ci accomuna una lunga tradizione di battaglie civili e sindacali.
«La Torino operaia piange per voi», c'è scritto su uno striscione del corteo. Poco tempo fa mi è capitato di leggere un bel libro di Alberto Papuzzi, «Quando torni». E' la storia di una coppia di operai nella Torino degli anni Settanta: la fatica del tirare avanti, le spese domestiche oculatamente gestite, l'impegno politico e sindacale che assorbe il poco tempo libero ma dà almeno la speranza di un cambiamento. E poi, fulcro di quel rapporto condizionato dal ritmo implacabile della fabbrica, un'agenda dove la coppia si scambia messaggi, rientrando o uscendo di casa, avvicendandosi nei turni di lavoro perché almeno uno dei due resti ad accudire le figlie. Struggente radiografia di una relazione che cerca, come e dove può, di ricavarsi spazi di intimità e di umanità. Abbiamo sentito tante volte in questi anni parlare di scomparsa della fabbrica. La tragedia della notte del 5 dicembre ci ha sbattuto in faccia la verità. La fabbrica non è scomparsa - con la Germania, l'Italia resta il paese europeo a più forte composizione operaia - ha solo perso peso e visibilità. Messa ai margini, con il suo grigiore e la sua dura materialità, i suoi ritmi massacranti e i suoi salari inadeguati, dalla società del luccicante e del virtuale. «E' la tragedia di un mondo senza rappresentanza e senza rappresentazione», scrive giustamente Marco Revelli. Invitato a parlare del libro, ho portato con me un oggetto donatomi anni fa da un operaio: una scatola metallica con un quadrante, rivestita di pelle e dotata di tracolla. E' lo strumento con cui i «cronometristi» controllavano che gli operai addetti alla catena di montaggio rispettassero i ritmi di produzione, strumento che le lotte degli anni Settanta erano riuscite ad accantonare, ma che la corsa ai profitti, il mercato assunto come parametro assoluto, ha reimposto nei fatti, senza che ci sia bisogno di un addetto, di una mano umana che schiacci il pulsante per avviare la lancetta del cronometro.
«Il lavoro è per l'uomo, non l'uomo per il lavoro». E' il 13 dicembre, giorno dei funerali. Nel Duomo, davanti all'altare, le bare di Antonio Schiavone, Roberto Scola, Angelo Laurino, Bruno Santino. Mi sento piccolo e balbettante di fronte a un dolore così grande. Come in altri funerali, mi accade d'incrociare gli sguardi dei famigliari e sentire addosso tutto il loro strazio, la loro disperazione. Celebro insieme al mio vescovo, Severino Poletto, ed altri preti della diocesi. Ad alcuni mi lega un rapporto di affetto e amicizia. C'è don Carlo Carlevaris, storica figura di prete operaio che tanto ha significato per la nostra città. Ci sono volti più giovani, come quello di don Toni Revelli, anche lui prete con un passato di fabbrica. Espressioni di una Chiesa capace d'immergersi nella storia delle persone, stare senza diaframmi dalla parte dei più deboli, dei più fragili, dei dimenticati. «Il lavoro è per l'uomo, non l'uomo per il lavoro» sottolinea il vescovo, ricordando la dottrina sociale della Chiesa, il dovere di coniugare la carità all'impegno per il cambiamento, al battersi per la giustizia di questo mondo, saldando cielo e terra: «mai più morti come queste, mai più lavoratori come questi che abbiamo portato qui in bara o i tre che ancora stanno lottando per sopravvivere».
Il volto di quegli operai. Gad Lerner ha fatto una toccante puntata dell'Infedele dalla sala del Comune di Torino, con il sindaco Chiamparino, gli operai della Thyssen, gli amici delle vittime, i sindacalisti. Sulla poltrona del sindaco era seduto Antonio Boccuzzi, l'operaio sopravvissuto all'incendio. C'è una parte d'Italia che sembra scoprire solo ora questi ragazzi, i loro volti e sguardi profondi, la loro capacità di analisi e proprietà linguistica. In una parola: la loro dignità, il loro essere, con un'intensità rara, persone. Eppure è una generazione invisibile, cresciuta nella fatica e nell'isolamento. Costretta a trovare nella solidarietà di gruppo il surrogato a una politica troppo spesso impegnata a parlare il linguaggio dell'io e non quello del noi. Ragazzi figli della grande trasformazione avvenuta tra gli anni Settanta e Ottanta, quando l'avvento delle nuove tecnologie non rese più necessario «spremere» gli operai perché l'automazione degli impianti era ormai in grado di rimpiazzarli. Furono 600mila, nel solo nord-ovest, quelli che tra l'80 e l'85 abbandonarono il posto di lavoro, mentre si affermava una malintesa idea di «modernità», la riduzione della persona a variabile del fatturato, accessorio della crescita economica. In un bell'articolo su Repubblica - «La Superga degli operai italiani» - Lerner vede nelle morti della TK il punto d'arrivo di un «tragitto d'umiliazione della Torino operaia» cominciato nell'ottobre del 1980, con la «marcia dei 40mila». Fu un punto di svolta. Per tanti quella sconfitta significò cassa integrazione, isolamento sociale, perdita d'identità. 150 di loro si tolsero la vita.
Don Milani e Gerolamo. Ieri sera, 20 dicembre - dopo il funerale di Rocco Marzo e la morte di Rosario Rodinò, sesto operaio deceduto - ci siamo riuniti alla sede del Gruppo Abele per farci gli auguri di Natale. La sede del Gruppo è in una ex fabbrica dell'indotto Fiat. L'abbiamo rimessa a posto e ribattezzata «Fabbrica delle e» perché diventi luogo per costruire incontri, relazioni, progetti. Luogo delle «e» quindi del «noi», della vita proiettata nella sua diversità e pluralità, nella sua inesauribile ricchezza. La ristrutturazione dello stabile, costata molta fatica e qualche azzardo economico, ha lasciato ben visibili alcune parti dell'antica struttura: i carroponte, i paranchi. L'antica anima operaia continua così ad accompagnarci nei nostri cammini, spesso aspri e tortuosi. Se è vero che speranza è avere fiducia anche nelle curve, la vita degli operai è da sempre molto avara di rettilinei.
Ieri sera abbiamo ricordato don Lorenzo Milani, la sua vita intensa e tormentata, il suo impegno per la libertà di coscienza, la sua vicinanza ai contadini e agli operai. Moriva 40 anni fa, proprio quando il Gruppo Abele cominciava a muovere i primi passi sulla strada, luogo di bisogni e domande sempre nuove, banco di prova di un impegno a cavallo tra concretezza e utopia. Gli operai della Thyssen sono entrati nel nostro Natale accompagnati dalle note di una vecchia canzone di Lucio Dalla, «L'operaio Gerolamo», storia di un ragazzo meridionale che arriva nella Torino degli anni Sessanta e muore sul posto di lavoro, odissea che ritroviamo oggi nelle biografie mutilate di tanti amici che arrivano da terre ancora più lontane. Mentre ascoltavamo le note della canzone, scorrevano sullo schermo le immagini dei volti di Antonio, Roberto, Angelo, Bruno, Rocco, Rosario e, a seguire, i nomi di tutti i lavoratori morti nel 2007. Sono state quasi 1000 quelle che, con equivoca espressione, vengono definite «morti bianche», quasi fossero morti senza storia né colpevoli, e non invece conseguenze di un sistema che antepone il profitto alla tutela della vita. Dobbiamo avere il coraggio di denunciare la fatalità solo apparente di quegli incidenti, il loro essere frutto di una disattenzione di cui dobbiamo sentirci tutti corresponsabili.
L'importanza dei segni. 3 gennaio: sotto un cielo cupo, mentre cade qualche fiocco di neve, accompagniamo l'ultima vittima, Giuseppe De Masi, 26 anni. Anche questa volta sono tanti gli operai presenti, con il loro dolore dignitoso, ma anche con la loro rabbia e la richiesta di verità. E' necessario che la magistratura accerti le responsabilità, faccia al più presto luce sulle cause della tragedia. Ma bisogna costruire le condizioni perché questo non accada più, impegnandoci tutti: aziende, sindacati, istituzioni, singoli cittadini. Il presidente Napolitano ce l'ha ricordato, lo scorso 1° maggio: «Non limitiamoci alla denuncia. E' assurdo che si debba morire sul lavoro. Morire inoltre per salari bassi, talvolta indecenti».
Sulla bara c'è la maglia di Alessandro Del Piero firmata da tutti i giocatori della Juventus, di cui Giuseppe era tifoso. Bei segni, come quello del sindaco Chiamparino, che ha deciso di annullare la festa di Capodanno prevista in piazza Castello e spegnere le luminarie natalizie. Come quello di Romano Prodi, accorso qualche giorno fa con la moglie Flavia nella chiesa di corso Giulio Cesare per partecipare al funerale di Rosario Rodinò, aggiungendo all'ultimo momento questa tappa torinese prima di partire alla volta di Kabul.
Le parole sono stanche. Percorrendo al ritorno la città ancora semideserta per le vacanze, penso che il rischio maggiore, ora, sia quello di dimenticare. Riabituarci ai silenzi che uccidono, alle reazioni innescate dall'emergenza, parola che dovremmo avere il coraggio di espellere dal vocabolario pubblico, troppo spesso alibi a interventi sporadici, facili sdegni, parole sospese al comodo limbo delle intenzioni. Non dobbiamo dimenticare, per stare vicino alle famiglie degli operai morti e a quelle di altri di cui poco o nulla si è parlato. Lo scorso 16 luglio, ad esempio, cinque persone sono saltate in aria nell'esplosione dentro una fabbrica, il «Molino Cordero» nei pressi di Cuneo. Ma era estate, e la morte Antonio Cavicchioli, Massimiliano Manuello, Valerio Anchino, Marino Barale, Mario Ricca, è passata quasi inosservata.
L'eredità di quella notte. Ieri, 14 gennaio, i giornali hanno parlato di un documento sequestrato all'amministratore delegato della Thyssen. In quel documento anonimo è scritto che le accuse mosse contro l'azienda sono «false e pesanti», che gli operai sono morti «perché si erano distratti ». Di Antonio, il sopravvissuto, andato più volte in tv a denunciare le condizioni d'insicurezza dello stabilimento, si dice che «va fermato con azioni legali». Parole che lasciano sconcertati, sgomenti. Tanto maggiore dovrà essere ora l'impegno per conoscere la verità della tragedia. Il nostro compito - penso in questi giorni di silenzio e di preghiera - non può limitarsi alla sola denuncia. Dobbiamo alimentare la speranza, impegnarci perché l'amore, la prossimità, la ricerca di verità vincano su egoismi, ingiustizie, menzogne.
Ricorre quest'anno il sessantesimo anniversario della Costituzione, di quel primo articolo che riconosce nel lavoro il fondamento della nostra democrazia. Non possiamo morire per il lavoro, per la mancata manutenzione di un impianto, per l'assenza di verifiche, per l'aggiramento delle norme di sicurezza. Ma non possiamo nemmeno vivere male con il lavoro, essere costretti a lavori mal retribuiti e privi di garanzie, impieghi senz'anima né futuro, decisi dalle logiche del profitto. Prima ancora che diritto riconosciuto, il lavoro è infatti un bisogno. Lavoriamo per crescere, per costruirci un'identità, per sentirci parte viva del contesto sociale, per essere liberi. Ridare dignità al lavoro è allora ridare dignità alle persone. E' questo il compito che ci lascia la tragedia della TK, questa la via indicata dalle troppe «morti bianche» che troppo silenziosamente hanno accompagnato sino a oggi il nostro cammino.
Luigi Ciotti - Fondatore del Gruppo Abele e presidente di Libera
Il Manifesto – 17 gennaio 2008